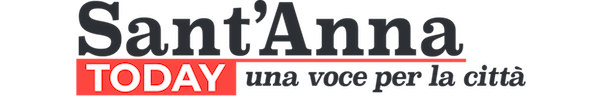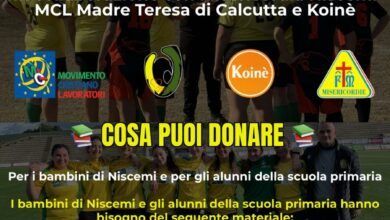“Mio Marito”: può funzionare replicando lo stesso metodo?

A Torino, lo street artist Andrea Villa ha trasformato alcuni manifesti in una provocazione visiva che cattura lo sguardo e il pensiero. Uomini in mutande, tratti dal gruppo Facebook “Mia Moglie”, appaiono al pubblico come oggetti da osservare, vulnerabili, esposti, senza difesa. Ironico e dissacrante, ma inquietante. Passanti che si fermano, ridono, si indignano, si scambiano commenti davanti a figure maschili impotenti di fronte agli sguardi altrui: un piccolo teatro urbano di disagio e riflessione. L’idea è chiara: far sentire agli uomini cosa significa perdere autonomia e privacy, come succede spesso alle donne.
Villa spiega che l’opera mette in discussione il concetto di possesso e il doppio standard sociale. Ricorda il caso della maestra licenziata per la sua attività su OnlyFans: mentre le donne vengono punite e stigmatizzate, gli uomini raramente subiscono conseguenze. “Mio Marito” diventa così un atto di resistenza e un riequilibrio simbolico. Nei manifesti affissi i protagonisti diventano loro: i mariti, esposti sulla piazza pubblica senza autorizzazione, con volti e contesti leggermente alterati, trasformati in simboli di una dinamica invisibile ma pervasiva.
Da una parte, il gesto sembra riuscito. Esporre gli uomini mette in luce contraddizioni legate al possesso dei corpi, al doppio standard e alla disparità nel decidere chi può mostrarsi e chi no. La mimesi critica provoca, fa discutere e porta un brivido di disagio: l’imbarazzo, l’inquietudine, la consapevolezza di ciò che per molti resta invisibile.
Dall’altra, però, restano dubbi inquietanti. Esporre qualcuno senza consenso, anche per denunciare un’ingiustizia, non rischia di replicare la stessa logica di dominio? Spostare l’attenzione sugli uomini potrebbe oscurare chi, quotidianamente, subisce controllo e violenza reale. E se la provocazione venisse fraintesa o banalizzata, cosa resta del messaggio originario? Come ci si sente quando ci si ritrova, all’improvviso, al centro di sguardi che non si è scelto di attirare?
Forse la questione centrale non ha risposta chiara. Un gesto artistico può davvero invertire le gerarchie senza diventare esso stesso un atto di dominio? Oppure ogni esposizione, anche simbolica, rischia di cadere nello stesso schema? E se l’obiettivo fosse solo far discutere, senza modificare nulla nelle abitudini e nelle mentalità?
Forse la lezione più potente non è nei manifesti, ma nella capacità di interrogarsi sul modo in cui viviamo, condividiamo e controlliamo corpi e immagini. Forse è nel brivido che proviamo davanti a quegli uomini esposti, nel disagio che ci coglie mentre ci vediamo riflessi nelle loro vulnerabilità, che possiamo capire quanto spesso ignoriamo il peso del controllo, della gelosia, della mercificazione dei corpi.
E alla fine, rimane l’immagine dei manifesti appesi al muro: uomini immobili, muti, con gli occhi degli estranei addosso. Noi li osserviamo e nello stesso tempo ci vediamo riflessi, interrogati. La scena resta sospesa tra ironia e inquietudine, tra provocazione e responsabilità. In quel silenzio carico di sguardi, Villa ci ricorda che forse il vero cambiamento non nasce dai manifesti, ma da come scegliamo di guardarci, e di guardarli, ogni giorno. È nella scelta di non ridurre l’altro a oggetto, di riconoscere la vulnerabilità altrui, di mettere in discussione le regole invisibili del possesso e dello sguardo che, forse, possiamo iniziare a cambiare davvero.
Manuela Acqua